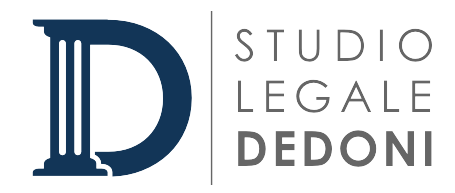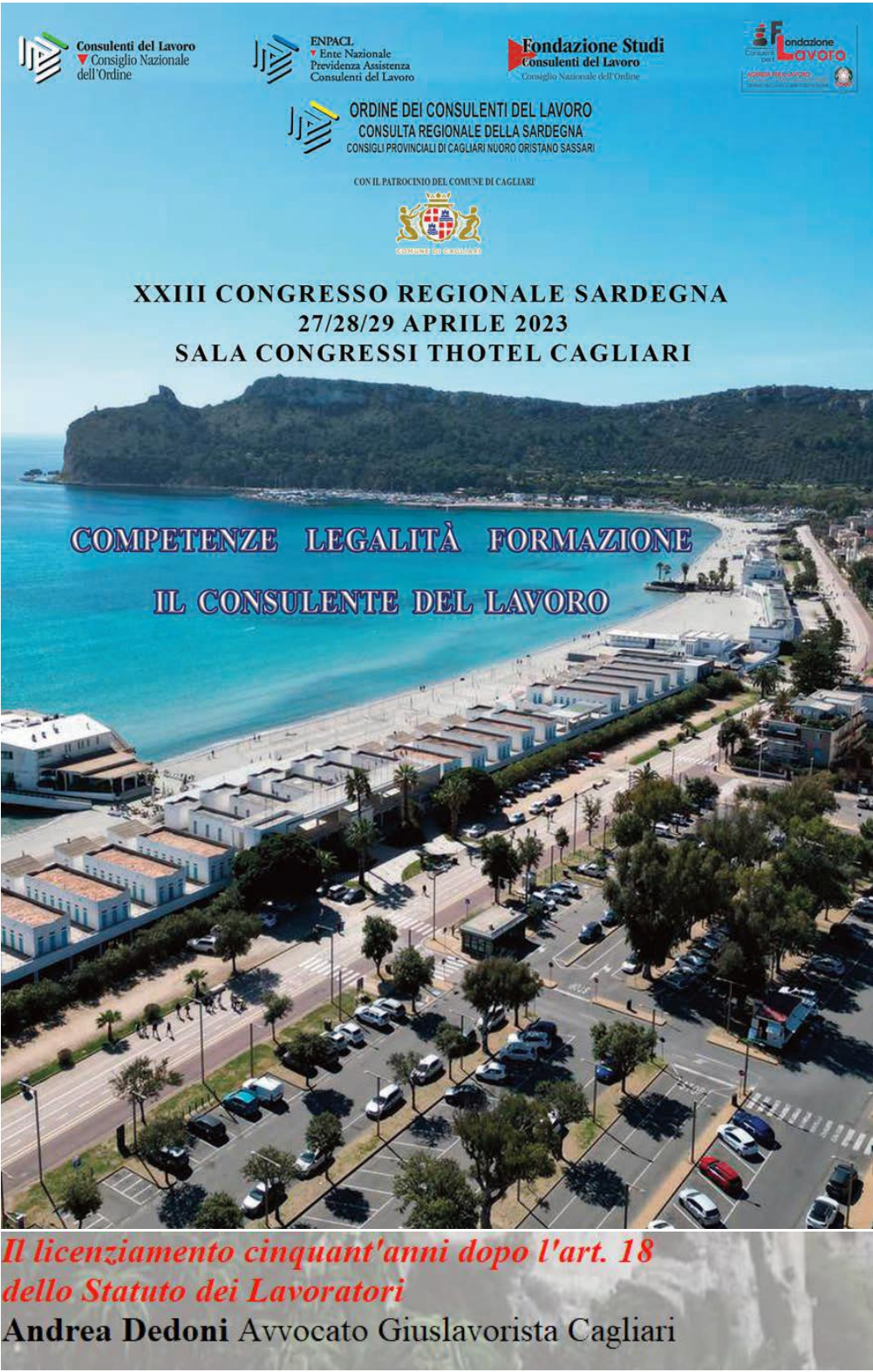
L’intervento dell’Avvocato Andrea Dedoni al XXIII Congresso Regionale Sardegna dei Consulenti del Lavoro
Lo Statuto dei Lavoratori è una legge longeva e resta dopo 50 anni un punto fermo nella legislazione del diritto del lavoro.
Cosa ha rappresenta ed ha rappresentato l’art.18 in tema di licenziamento e perché è stato così importante nella stabilità dei rapporti di lavoro?
Bisogna chiarire che prima del 1966, prima della Legge 604 del 1966, l’ordinamento italiano in tema di rapporti di lavoro era totalmente piegato alla libertà di impresa tanto che il concetto di stabilità del rapporto di lavoro non era preso in nessuna considerazione.
Prima del 1966, prima della Legge 604 del 1966 in realtà non esisteva il licenziamento, nella comune accezione odierna riguardante il contratto di lavoro e inteso come recesso datoriale che deve essere sempre e comunque essere motivato.
Esisteva il recesso quale istituto generale del diritto civile, un negozio astratto, con l’unico limite al potere di recesso ordinario nell’obbligo di dare un preavviso perché si riteneva che il preavviso fosse l’unica possibile restrizione al principio secondo cui nessuno può restare vincolato in perpetuo da un impegno contrattuale.
Non è questa una particolarità perché nei contratti a tempo indeterminato, nell’ambito della normale fisiologia dei contratti a tempo indeterminato, può ancora essere considerata una norma generale perché il nostro ordinamento non vede di buon occhio i contratti a tempo indeterminato senza che esista la possibilità per ciascuna delle parti di sciogliersi dal vincolo contrattuale.
Ed infatti un paradigma codicistico fissato nell’art.2118 che in merito alla estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato prevede che: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dandone preavviso nel termine o nei modi previsti dai CCNL dagli usi o dall’equità”, con l’unica sanzione prevista per il caso di mancato rispetto del preavviso del pagamento della relativa sanzione.
Ovviamente essendo la regola quella del recesso libero era esclusa in radice qualsiasi forma di controllo giudiziale.
Da tale discorso va escluso il recesso per inadempimento, che attiene ad una fase patologica del contratto, in quei casi nei quali l’inadempimento, nel diritto del lavoro la condotta illegittima del lavoratore ovvero del datore di lavoro, non consente nemmeno provvisoriamente la prosecuzione del rapporto di lavoro, che nel diritto del lavoro corrisponde al licenziamento in tronco per giusta causa che si ritrova nell’art.2119 del c.c.
Bisogna in principio chiarire che la legislazione del lavoro risente più di ogni altra delle influenze della politica e delle condizioni sociali.
Pensiamo allo stravolgimento delle norme del lavoro nel periodo della pandemia, al blocco dei licenziamenti, ma pensiamo anche alle norme in materia di tutela delle lavoratrici madri.
Il 1970 era caratterizzato da una notevole incidenza del sindacato nelle fabbriche metalmeccaniche. Lo Statuto non è solo l’art18 ma è la legge della rappresentanza sindacale all’interno delle fabbriche è l’anno in cui si comincia a parlare di compromesso storico: non è forse un caso che Berlinguer venne eletto segretario del PCI nell’anno 1972.
La legge n. 604/1966 innanzitutto “nomina” l’atto giuridico, strappandogli la maschera di “negozio astratto”. In secondo luogo inserisce molti altri vincoli al potere di recesso del datore di lavoro oltre il preavviso: vincoli formali, procedurali e motivazionali. In terzo luogo rende sempre invocabile il controllo giudiziario, per di più addossando ex lege al datore di lavoro l’onere della prova della motivazione del licenziamento.
Quali erano le tutele previste inizialmente dalla Legge 604 del 1966 per il lavoratore licenziato ingiustamente?
Si trattava di garanzie piuttosto blande che prevedevano la tutela obbligatoria, con un’indennità compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione e l’esclusione dal campo di applicazione della legge i datori di lavoro che occupano fino a 35 dipendenti.
Con tutti i suoi limiti, la legge del 1966 segna per la regolamentazione del licenziamento la fine dell’epoca della libera recedibilità ed il passaggio ad un regime di un diritto speciale nel quale il potere illimitato del datore di lavoro di recedere dal rapporto a tempo indeterminato non costituisce più un principio generale del nostro ordinamento.
Come si arriva allo Statuto dei lavoratori che è invece è posteriore perché emanato nel 1970? Quale è stata davvero la portata innovativa dell’art.18 dello Statuto e quando è stata scritta la norma che è restata in vigore fino all’anno 2012?
Nella versione originaria dell’articolo 18 della legge n. 300/1970, veniva introdotto l’obbligo di reintegra in tutti i casi di licenziamento illegittimo (la c.d. tutela reale).
La norma prevedeva che, in tutti i casi di licenziamento illegittimo, il giudice ordinasse al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e lo condannasse al risarcimento del danno subito per il licenziamento, in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione.
L’articolo 18 ha dunque costituito una vera e propria rivoluzione nell’ordinamento giuridico, nel momento in cui ha travalicato i confini di una tutela di carattere meramente economico.
Si è sin da subito dimostrata come una tutela incompleta, dalla quale restavano esclusi tutti i lavoratori occupati nelle imprese di piccole dimensioni, sotto i 15 dipendenti che non avevano nessuna tutela, nemmeno quella risarcitoria.
Venne quindi proposto, da parte di un partito politico di estrema sinistra, un referendum popolare per abrogare l’articolo 35 dello Statuto, che limitava, prima della modifica intervenuta con legge n. 108/1990, l’applicazione dell’articolo 18 ai soli datori di lavoro che occupassero più di quindici dipendenti, o cinque nel caso di imprese agricole.
Nonostante la dichiarazione di ammissibilità del referendum, avvenuta con sentenza del 22 febbraio 1990, n. 65 della Corte Costituzionale, l’Ufficio per il referendum presso la Corte di Cassazione ha escluso la necessità del referendum, atteso che, pochi mesi dopo la sentenza della Corte Costituzionale, veniva approvata la legge n. 108/1990, che accoglieva le istanze sottese al referendum, estendendo il campo di applicazione della tutela reale, rendendo applicabile la tutela obbligatoria dettata dalla legge n. 604/1966 ai lavoratori occupati nelle piccole unità produttive.
La Legge 108/1009 è la legge che ha riscritto l’art.18 dello Statuto nella versione che è durata fino al 2012.
Nello specifico, la legge n. 108/1990 che ha riscritto i primi 5 commi dell’art.18 ha esteso la tutela reale anche ai datori di lavoro non imprenditori e dettato nuovi requisiti per il computo dei prestatori di lavoro occupati dal datore ed ha inoltre ha attribuito al lavoratore la possibilità di scegliere se essere reintegrato o richiedere l’indennità sostitutiva della reintegra istituendo il così detto diritto di opzione che legittima la scelta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni di accettare la reintegrazione ovvero di rifiutarla con la corresponsione in tale ultimo caso, di una indennità risarcitoria di 15 mensilità.
Il diritto di opzione è proprio lo stesso che troviamo nell’odierno art.18 al comma 3 nella formulazione modificata dalla Legge 92 del 2012.
Neanche la riformulazione dell’articolo 18 ad opera della legge del 90’, ha però posto fine alle contestazioni dottrinali: la disposizione veniva accusata di rappresentare la principale causa di rigidità dei rapporti di lavoro; non era di opinione diversa gran parte della giurisprudenza, che di fatto aveva già cominciato a ristringere ulteriormente il diritto del lavoratore ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro.
Io ricordo bene che i datori di lavoro con più di 15 dipendenti avevano davvero l’idea che non si potesse licenziare anche se come è ovvio, fermo il fatto che il licenziamento illegittimo doveva essere sempre sanzionato, ciò che cambiava era l’entità della sanzione.
Facendosi portatore dello scontento del mondo imprenditoriale, il partito radicale ha quindi proposto un referendum per l’abrogazione dell’articolo 18 che, se avesse avuto esito positivo, avrebbe esteso la tutela economica prevista dalla legge del 1966 a tutti i casi di licenziamento ingiustificato con la sola eccezione dei licenziamenti discriminatori o nulli per altre ragioni, ai quali si sarebbe applicato, venuto meno l’articolo 18, il regime della nullità di diritto comune.
Il referendum tenutosi il 15 giugno 2003 non ha tuttavia raggiunto il quorum necessario per la validità del risultato ed il numero dei votanti non raggiunse neanche il 30% del corpo elettorale; l’astensione fu la scelta della maggioranza degli elettori.
Quale è stato l’effetto pratico dell’art.18, durante la sua vigenza?
L’effetto è stato una grande battaglia di cui è stata protagonista soprattutto la giurisprudenza, con scarsi contributi del legislatore ma anche della contrattazione collettiva che era appiattita sulla volontà sindacale.
Ne è scaturita una mole davvero grande di contenzioso. Io ne ho vissuto direttamente l’esperienza, si era ingenerata la convinzione, come ho già detto che il licenziamento nelle aziende con più di 15 dipendenti fosse vietato. Ciò che veniva percepito come ingiusto più di ogni altra cosa che in caso di licenziamento pacificamente assistito da giusta causa o giustificato motivo, per un solo errore formale di procedura veniva applicata la reintegrazione con sentenze che arrivavano dopo anni di processo e con le corrispondenti retribuzioni che dovevano essere erogate in unica soluzione.
Nel corso degli anni la giurisprudenza, ha fatto evolvere la norma anche nell’intreccio con altri istituti, penso alla decorrenza della prescrizione che non decorreva durante il rapporto di lavoro nelle sole imprese con più di 15 dipendenti, penso all’onere della prova per esempio in ordine alla prova della sussistenza del requisito dimensionale, da principio in capo al lavoratore e successivamente ed ancora oggi in capo al datore di lavoro.
Credo di essere obbiettivo se dico che in generale i Giudici avevano un occhio di riguardo per i lavoratori, per esempio nella liquidazione delle spese di causa che difficilmente venivano poste a capo del lavoratore soccombente. Qualcuno mi dirà che ancora oggi è così ma io credo invece che questa tendenza stia mutando. La questione in parole più semplicistiche può essere liquidata con la percezione da parte della magistratura di un contraente forte, il datore di lavoro e di un contraente debole, il lavoratore. Su tale posizione asimmetrica dei soggetti contrattuali si è modellata la giurisprudenza dal 1990 al n2012.
Ha ancora un significato oggi la tutela del contraente debole che è sempre individuato nel lavoratore?
Esiste ancora un contraente debole nei rapporti di lavoro?
A me sembra che la contrapposizione tra parti contrattuali, forte e debole sia oggi nella maggior parte dei casi superata perlomeno in termini concettuali. Propenderei per considerare entrambi i soggetti del rapporto di lavoro deboli per cause diverse: il lavoratore per la posizione socio-economica che evidentemente più è collocata in basso e più comporta fragilità, il datore di lavoro per le oggettive difficoltà di sopravvivenza nel mercato soprattutto in Italia legate all’alto costo degli elementi della produzione e dell’impiego della mano d’opera.
Come abbiamo detto il diritto è il frutto di equilibri che si determinano fuori del mondo delle norme: è uno degli strumenti della politica, che può essere utilizzato in molteplici direzioni e con modalità diverse, risultando diversamente efficace ed effettivo.
Penso che l’interesse alla conservazione del posto di lavoro oggi assuma e debba assumere connotati diversi da quelli di 50 anni fa. Indubbiamente la precarietà non è una categoria astratta, statica, giuridicamente definibile, ma va costruita a ridosso dello specifico modo di lavorare e al tipo di contratto non standard che accompagna il lavoratore precario in carne e ossa. E questo sacrosanto rilievo può indurre ad articolare i rimedi contro la precarietà, adeguando norme e tutele alle condizioni soggettive e oggettive, spesso determinate dalle dinamiche di mercato. E relativizzando la nozione di “stabilità” meritevole di tutela, cosa che lentamente si sta facendo.
Cosa resta oggi delle riforme della legislazione degli anni 60? La Legge Fornero è stata davvero una legge di portata innovativa che ha permesso di graduare le tutele in caso di licenziamento illegittimo?
Che impatto ha avuto sotto il sotto il profilo processuale quello che comunemente è stato chiamato “Rito Fornero”?
La Legge 92 del 2012 “Legge Fornero”
Il legislatore di oggi ha poco in comune con quello del 1966. L’intento esplicito è diretto a ridurre il potere discrezionale del Giudice assicurando al datore di lavoro uno strumento sanzionatorio graduato a seconda del grado di illeceità del recesso ma in qualche assicurandogli la possibilità di prevedere a priori il costo della sanzione. Questo non era possibile con il vecchio art.18, sia perché la sanzione era lineare rispetto a tutte le forme di illiceità e sia perché di fatto quello che determinava l’entità delle somme da corrispondere al lavoratore in caso di reintegrazione era la durata del processo, una leva che il datore di lavoro non poteva controllare.
Questo intento dichiarato della Legge Fornero non è stato raggiunto a causa del grado di complessità sistemiche della legge.
L’intento del Governo era, come detto, quello di un integrale superamento della tutela reale e di generalizzare quella obbligatoria, ma la forte reazione sindacale portò ad operare una rimodulazione delle tutele, differenziate a seconda della gravità del vizio del licenziamento e delle dimensioni del datore di lavoro.
La nuova regolazione del 2012 la così detta Legge Fornero si basa su una evidente enfatizzazione del “fatto” posto a base del licenziamento, che, ideata per ridurre al minimo il controllo giudiziario sul recesso, finisce per avvitare la normativa in una serie di contraddizioni giuridiche e logiche. Per uscire dalle contraddizioni e recuperare una qualche razionalità si parla di giudizi “bifasici” o, addirittura, “trifasici”, in cui l’apprezzamento della legittimità del licenziamento passerebbe attraverso una valutazione distinta: della materiale sussistenza del fatto posto a base del licenziamento, della sua conformità a tutti i requisiti o presupposti previsti dalla legge; dell’individuazione della tipologia/entità della sanzione che avrebbe una regolazione autonoma di carattere tanto sostanziale quanto processuale.
COMMA 1 LA TUTELA REALE
Con la legge n. 92/2012, la tutela più incisiva, quella reale, viene mantenuta con riguardo ai licenziamenti nulli o inefficaci perché intimati in forma orale, a prescindere dal motivo formalmente addotto e dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro. La tutela reintegratoria si applica dunque anche ai datori di lavoro di piccole dimensioni, perché discriminatori ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (ragioni politiche, sindacali, religiose o legate alla razza, alla lingua, al sesso, ad handicap, all’età all’orientamento sessuale o alle convinzioni personali), ovvero intimati in concomitanza col matrimonio ai sensi dell’articolo 35 del codice della pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni, o, ancora, perché riconducibili ad altri casi di nullità previsti dalla legge o in quanto fondati su un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile.
Se vogliamo individuare due grandi categorie di licenziamenti nulli all’interno del primo comma dell’art.18 nella nuova versione della 92 del 2012 direi che il licenziamento discriminatorio è tipizzato, perché previsto solo e soltanto nei casi indicati dalla norma ovvero a quei casi previsti da altre norme espressamente richiamate, mentre invece il licenziamento determinato, unicamente determinato, da motivo illecito determinato ricomprende tutti i casi di licenziamento dove la motivazione sia di carattere ritorsivo con la prova di tale elemento che deve essere determinante, sempre in capo al lavoratore.
COMMA 2 LA CONDANNA AL RISARCIMENTO
Nei casi di tutela reale sopra esaminati, il giudice che abbia accertato l’illegittimità del licenziamento, accanto all’ordine di reintegra (che deve avvenire con riferimento alle stesse mansioni e nello stesso luogo in cui il lavoratore era occupato al momento dell’atto illegittimo, salvo il caso di assoluta impossibilità), condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno, determinato in un’indennità (mai inferiore a cinque mensilità) commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell’avvenuta reintegrazione, dedotto quanto percepito durante il periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative (c.d. aliunde perceptum).
COMMA 3 IL DIRITTO DI OPZIONE
In sostituzione della reintegrazione, il lavoratore può richiedere un’indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (purché la richiesta intervenga entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza che ha disposto la reintegrazione o dall’invito del datore di lavoro a riprendere il servizio, se precedente alla prima).
COMMA 4 LA TUTELA REALE ATTENUATA
Dopo la tutela reale, in ordine di gravità decrescente del vizio del licenziamento, si pone la tutela reale attenuata (che trova applicazione unicamente nei confronti dei datori di lavoro che occupino più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo), costituita dalla reintegrazione nel posto di lavoro e da un’indennità risarcitoria, della quale è previsto un importo massimo (pari a 12 mensilità di retribuzione globale di fatto) ma non è previsto un importo minimo (a differenza che per la tutela reale piena). La relativa tutela (detta reale “attenuata” in quanto non assicura il risarcimento integrale del danno), è disposta nel caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per l’insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili (secondo le disposizioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili) con sanzione conservativa. Dalla stessa deve poi essere detratto, oltre che l’aliunde perceptum, anche l’aliunde percipiendum ovvero quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire ove si fosse dedicato con diligenza alla ricerca di una nuova attività lavorativa.
COMMA 5 TUTELA OBBLIGATORIA FORTE
La tutela c.d. obbligatoria opera, come detto, nelle altre ipotesi in cui si accerti che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo (soggettivo o oggettivo): in tali casi il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria «onnicomprensiva», determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto di determinati fattori eterogenei (numero di dipendenti occupati, dimensioni, comportamento e condizioni delle parti); in aggiunta a tali criteri, nel caso di difetto di giustificato motivo oggettivo, il giudice deve tener conto anche delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento tenuto da entrambe le parti nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 7 della legge n. 604/1966.
COMMA 6 TUTELA OBBLIGATORIA ATTENUATA
Infine, una tutela risarcitoria ridotta (c.d. tutela obbligatoria attenuata, anch’essa, come la reale attenuata e l’obbligatoria piena, applicabile ai datori di lavoro che occupino più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo), è prevista nei casi di inefficacia del licenziamento derivante dalla mancata indicazione dei motivi che lo hanno determinato (art. 2, comma 2, della legge n. 604/1966) o dalla violazione della procedura che il datore di lavoro è tenuto a rispettare quando intenda intimare un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (oggettivo o soggettivo); in tal caso l’indennità è ricompresa tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità di retribuzione.
COMMA 7 ALTRE IPOTESI DI TUTELA REALE ATTENUATA
La tutela reale attenuata del comma 4 parimenti, troverà applicazione nel caso in cui il giudice accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, intimato in violazione del diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro durante la malattia ai sensi dell’articolo 2110 c.c.
Il Giudice (può altresì applicare) applica dopo la Sent. Corte Cost.59/2011, qualora accerti la «manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» Sent. Corte Costituzionale 125/2022;
Negli altri casi nei quali accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo applica la tutela del 5 comma risarcimento forte.
Quanto al primo gruppo di ipotesi (difetto di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo), accanto ai dubbi sollevati dalla dottrina in ordine al richiamo ai contratti collettivi per la distinzione tra sanzione conservativa o non, emergono quelli che coinvolgono la centrale rilevanza attribuita ai codici disciplinari, la cui forza vincolante è fortissima: quando una condotta è punibile con sanzione conservativa, la scelta negoziale condiziona la tutela applicabile, sicché il datore di lavoro, potrebbe essere spinto a non applicare alcun contratto collettiva o alcun codice disciplinare al fine di ridimensionare l’operatività della reintegrazione.
DATORI SENZA REQUISITO DIMENSIONALE
Resta la tutela reale dei commi 1 e 3 uguale a quella degli imprenditori con il requisito dimensionale per il caso di licenziamento nullo o intimato in forma orale e nel caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo oggettivo si applica l’art.8 della L.604/66 che prevede una obbligazione alternativa, consistente nella possibilità per il datore di lavoro di optare per la riassunzione del lavoratore (che si badi bene differisce dalla reintegrazione perché richiede un nuovo atto negoziale tra le parti, entro tre giorni dall’ordine giudiziale o, in alternativa, il pagamento di una indennità da 2,5 a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, che può essere aumentata fino a 10 mensilità per i lavoratori con anzianità superiore a 10 anni e fino a 14 mensilità per il lavoratore con anzianità superiore a 14 anni.
Cosa comporta la complessità delle norme contenute nella Legge Fornero?
Comporta una notevole incertezza nell’affrontare il contenzioso anche in ragione dei mutamenti recenti della giurisprudenza.
La norma è complicata, oggetto di successivi rimarginamenti da parte della Giurisprudenza della Corte Costituzionale di cui uno recentissimo portato nella Sent. Corte Cost. 125/2022
La Corte costituzionale, con la Sentenza n. 125 del 2022, è intervenuta per la seconda volta sull’art. 18 comma 7 della Legge 20 maggio 1970 n.300, secondo periodo, Statuto dei Lavoratori, che disciplina la reintegrazione attenuata nella parte in cui prevede che: “Applica altresì la predetta disciplina (il 4 comma dello stesso articolo 18) nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”. L’attenzione della Corte si focalizza sul concetto di “manifesta insussistenza del fatto” che, solo per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a differenza di quello intimato per giusta causa, è posta a base della sanzione della reintegrazione.
Si è detto che è la seconda volta che la Corte Costituzionale interviene sul comma 7 dell’art.18 perché nella originaria formulazione dettata dalla Legge 92 del 2012, il Giudice, in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento, poteva e non invece doveva, applicare la tutela reale.
Con la Sentenza n. 59 del 2021 la Corte Costituzionale ha invece stabilito che la manifesta insussistenza del fatto debba e non possa determinare la reintegrazione, ritenendo l’opzione irragionevole e priva di criteri univoci per la decisione demandata al Giudice che, di fatto, non aveva nessuna indicazione utile per l’applicazione ovvero la disapplicazione della reintegrazione.
La Corte di Cassazione si concentra sulla ragionevolezza del criterio dell’insussistenza “manifesta”, un requisito previsto solo per i licenziamenti per motivo oggettivo e non per quelli intimati per giusta causa.
Il presupposto per la pronuncia di reintegrazione in entrambe le fattispecie risiede nella nozione di insussistenza del fatto che costituisce il presupposto dell’illegittimità. In entrambi i casi resta sempre in capo al datore di lavoro fornire la prova dell’effettiva esistenza del fatto posto a motivazione del licenziamento.
Osserva la Corte che il requisito del carattere “manifesto” dell’insussistenza è indeterminato e che nella prassi è problematico il discrimine tra l’evidenza conclamata dell’inesistenza del fatto e la sua inesistenza pura e semplice.
Si tratterebbe di affidare al Giudice un apprezzamento imprevedibile e totalmente soggettivo non ancorato a nessun punto di riferimento con l’applicazione di due regimi sanzionatori profondamente diversi. Appare peraltro evidente che la sussistenza di un fatto ovvero la sua insussistenza, non si presta a particolari interpretazioni ma chiama il Giudice ad un accertamento semplice in termini positivi o negativi.
Il carattere di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento sembra piuttosto porsi in relazione con la facilità ed immediatezza dell’accertamento richiesto al Giudice e niente ha invece a che fare con il disvalore del recesso datoriale che anzi, proprio nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è il più delle volte conseguente ad un accertamento probatorio complesso.
Quanto detto evidenzia come la più grave sanzione della reintegrazione viene legata ad un criterio che non riguarda la gravità del vizio del licenziamento ma piuttosto ad un criterio assolutamente accidentale della complessità dell’accertamento della esistenza del vizio.
Conclude in tal senso la Corte dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma, limitatamente alla parola “manifesta” per l’irragionevole contrasto con i fini enunciati dall’art.1 lettera c della Legge 92/del 2012 che sono quelli di una più equa redistribuzione delle tutele dell’impiego.
La Sentenza della Corte, con lo stesso metodo utilizzato nella Sentenza n. 59 del 2021, elimina solo e soltanto la parola della disposizione che rende la norma contraria alla Costituzione e cioè il carattere “manifesto” dell’insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, senza che sia pertanto necessario un successivo intervento del legislatore: la mera e non più la manifesta insussistenza del fatto, determina necessariamente l’applicazione della tutela reale seppure nella forma attenuata.
La declaratoria di illegittimità costituzionale non esclude l’estensione degli effetti della Sentenza 125 del 2022 ai rapporti di lavoro sorti anteriormente ad essa, purché ancora pendenti.
L’impatto dell’elisione di un singolo vocabolo dal testo della norma appare di non poco conto. Di fatto, secondo l’interpretazione più aderente alla riscrittura della norma, ogni singola carenza, non necessariamente più manifesta, di uno dei requisiti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, può integrare l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento e dunque l’applicazione della tutela reale, di fatto limitando l’ipotesi della tutela risarcitoria ad ipotesi residue.
Resta dunque da chiarire quale sia l’ambito applicativo del comma 7 nel suo terzo periodo “nelle altre ipotesi nelle quali accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al comma 5” (tutela risarcitoria) nella parte in cui applica la tutela indennitaria ad ipotesi di licenziamento privo di giustificato motivo oggettivo ma che siano al contempo connotate dalla sussistenza del fatto perché l’intervento della Corte costituzionale finisce per delineare una norma assolutamente contraria alla ratio della Legge 92 del 2012 che, dichiaratamente, era orientata a circoscrivere la tutela reale alle sole ipotesi più gravi di illegittimità del licenziamento.
Restano inoltre da chiarire i rapporti della nuova formulazione della norma con quei licenziamenti nei quali il giustificato motivo oggettivo è svincolato da necessità legate al risparmio o alle perdite economiche ed invece il fatto posto a base del licenziamento può identificarsi in un riassetto organizzativo aziendale adottato per mere finalità di lucro finalizzate al maggiore profitto.
In merito al difetto di giustificato motivo oggettivo, i fatti che il giudice è chiamato a valutare prescindono dalla volontà del lavoratore o dalla loro valutazione di inadempimento, inerendo unicamente nelle ragioni tecnico – produttive dell’impresa. Ne consegue che, affinché possa operare la tutela reintegratoria, non rileverà unicamente la giustificazione fondata su un motivo pretestuoso o addirittura falso, ma anche e semplicemente l’assenza di un nesso causale tra le scelte tecnico – produttive ed il licenziamento del lavoratore.
Ma allora anche la violazione dell’obbligo di repêchage può dare luogo ad una sentenza di reintegrazione?
Assolutamente si ed in tal senso ormai è orientata in maniera conforme la Giurisprudenza in totale difformità di quanto fino ad oggi accaduto.
Segnalo la Sentenza della Corte di Cass.dell’11.11.2022 n.33341 che proprio in tal senso che richiama esplicitamente la sentenza della corte costituzionale n.125 del 2022.
Inutile dire che la prova dell’impossibilità del repêchage che è posta in capo al datore di lavoro, è particolarmente complicata soprattutto per quei datori di lavoro che impieghino molti lavoratori in diverse entità territoriali.
A riprova della assoluta incertezza interpretativa della norma, in questo caso con riferimento al comma 4 dell’art.18 segnalo una recente modifica dell’indirizzo giurisprudenziale anche in tema di giusta causa di licenziamento, contenuto nella Sentenza della Corte di Cassazione del 30 marzo 2022 n.11665/2022 che consente al giudice, in presenza di clausole elastiche del CCNL nella sua parte disciplinare, di collocare la condotta accertata come illecita del lavoratore nell’ambito delle sanzioni conservative.
Questo comporta che parte di quelle controversie che erano decise con l’applicazione della tutela risarcitoria prevista dal comma 5 dell’art.18, potranno adesso essere invece decise con l’applicazione della tutela reintegratoria.
Il grande dibattito circa la corretta interpretazione da attribuire alla frase “insussistenza del fatto contestato” che si ritrova nel 4 comma dell’art.18 nella nuova formulazione dettata dalla Legge 92 del 2012.
La nozione di “insussistenza del fatto contestato” che troviamo nel comma 4 dell’art.18 nella nuova formulazione, la locuzione “insussistenza del fatto contestato” introdotta nella norma ha destato sin da subito diversi dubbi interpretativi, che si sono concentrati in particolar modo sull’individuazione della natura giuridica del concetto di “fatto” ed hanno dato vita a due orientamenti contrapposti.
Da un lato, la teoria del “fatto materiale”, di matrice per lo più dottrinaria, secondo la quale l’indagine relativa al fatto contestato dovrebbe rivestire il mero fatto storico, il fatto materiale, per l’appunto, considerato nelle sue componenti oggettive (condotta, nesso causale ed evento, di matrice penalistica) e come tale naturalisticamente inteso e privo di ogni profilo soggettivo e normativo.
Ciò al fine di non tradire quella che era stata individuata come la ratio della riforma: se l’indagine sul fatto, infatti, fosse condotta sugli stessi elementi che hanno portato il Giudice ad accertare l’assenza della causa giustificativa del licenziamento, si finirebbe con il far conseguire sempre la tutela reintegratoria, così risultando vanificata la diversificazione dei regimi sanzionatori introdotta dal legislatore in seno all’art. 18 Stat. Lav.
Dall’altro, la teoria del “fatto giuridico”, di matrice giurisprudenziale, secondo la quale l’art.18, co.4, Stat. Lav., allorquando demanda l’indagine dell’organo giudicante sul fatto, fa necessariamente riferimento al c.d. fatto giuridico, inteso come il fatto globalmente accertato, nell’unicum della sua componente oggettiva e di quella inerente l’elemento soggettivo.
Differentemente, sempre secondo la giurisprudenza citata, si correrebbe il rischio di offrire una lettura della norma palesemente in violazione dei principi generali dell’ordinamento civilistico, relativi alla diligenza ed alla buona fede nell’esecuzione del rapporto lavorativo che è contratto tipico e come tale soggiace all’applicazione delle norme dettate in materia di contratti in generale, posto che potrebbe giungere a ritenere applicabile la sanzione del licenziamento meramente indennitaria, anche a comportamenti esistenti sotto l’aspetto materiale ed oggettivo, ma privi dell’elemento psicologico, o addirittura privi dell’elemento della coscienza e volontà dell’azione.
Sulla base della teoria del fatto giuridico, il Giudice sarebbe quindi chiamato a valutare il fatto nella sua componente oggettiva e soggettiva (in senso giuridico, per l’appunto) e, in assenza della componente soggettiva, potrebbe ritenere insussistente il fatto medesimo, disponendo la reintegra del prestatore di lavoro. Così probabilmente, secondo quale interprete, finendo con il far rientrare quella discrezionalità del giudice e, in ogni caso, un giudizio di proporzionalità dello stesso, che l’impianto della riforma Fornero pareva voler eliminare o comunque ridurre fortemente.
La giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in seguito al sorgere degli orientamenti innanzi descritti – fatto salvo per una sola pronuncia (Corte di Cass sentenza n. 23669 del 06/11/2014) che probabilmente ha finito per ispirare il Legislatore nel dettare la disciplina del Jobs Act e che pareva dare risalto al fatto materiale pur senza mai definirlo, ha preso una netta posizione, orientandosi verso una lettura estensiva dell’art.18 Stat. Lav., e pertanto volta a non limitare il concetto di “fatto” al semplice accadimento storico – naturale, ma comprendendo nel giudizio anche i profili di illeceità della condotta, evidenziando la necessità di verificarne l’imputabilità al lavoratore e la gravità. E così accedendo, almeno formalmente, alla tesi del “fatto giuridico”.
E’ ormai pacifico in Giurisprudenza, si veda Corte di Cassazione n.20540 del 13 ottobre 2015, che il fatto, costituente il presupposto del licenziamento, per essere sussistente, debba essere qualificabile come vero e proprio inadempimento imputabile al lavoratore e che quindi a rilevare, oltre che la mera sussistenza del fatto, è anche la sua qualificazione giuridica e la sua rilevanza disciplinare, del tutto slegato da qualsiasi aggancio oggettivo resta il margine di discrezionalità del Giudice nell’attribuzione di tale carattere al comportamento posto in essere dal lavoratore.
Vedremo a tale proposito come lo stesso percorso giurisprudenziale sia stato compiuto a proposito dell’interpretazione del secondo comma dell’art. 3 del DLGS 23/2015 Jobs Act, a mio parere contro il suo contenuto letterale che era finalizzato a togliere ogni discrezionalità al giudice limitando il suo potere all’accertamento del solo fatto materiale.
Il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23. Il “Jobs Act”
Perché sono rimaste due leggi differenti che si basano solo e soltanto su un criterio di temporalità? Questa differenza comporta delle disparità di trattamento tra lavoratori in identica situazione?
La versione dell’articolo 18 così come modificata dalla Legge Fornero è tutt’ora vigente, ma destinata ad un progressivo esaurimento in quanto riservata unicamente ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, anno in cui è entrato in vigore il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 noto come Jobs Act (uno degli otto decreti attuativi della legge delega n. 183/2004), che ha istituito il contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti.
Tale nuovo regime restringe ulteriormente l’ambito di applicazione della tutela reale, di fatto limitandolo ai licenziamenti nulli.
A differenza della legge n. 92/2012, che ha inciso direttamente sul testo dell’articolo 18 dello Statuto, introduce una disciplina parallela del licenziamento individuale, applicabile ai lavoratori (esclusi i dirigenti) assunti dal 7 marzo 2015.
Questa tecnica legislativa come vedremo ha prodotto una disparita di trattamento che non pare in nessun modo giustificabile.
Il d.lgs. 23/2015 mira in maniera evidente e dichiarata a limitare il potere del Giudice elidendo di fatto il parametro della proporzionalità, quantomeno prima dell’intervento della Sentenza della corte Costituzionale e della modifica del dl 12 luglio 2018 n.87.
Lo scopo dichiarato è sempre quello di mettere il datore di lavoro a priori nella condizione di poter valutare il costo di una eventuale dichiarazione di illegittimità del licenziamento forzando il concetto di proporzionalità.
ARTICOLO 2 LA TUTELA REALE
La tutela reale rimane ferma per il licenziamento nullo o intimato in forma orale; varia tuttavia il parametro di riferimento dell’indennità risarcitoria, commisurata non più all’ultima retribuzione globale di fatto ma all’ultima «retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione».
Ulteriore novità sta nel fatto che, per l’individuazione del campo di applicazione della tutela in questione, si fa riferimento al licenziamento nullo perché discriminatorio ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 300/1970 o perché riconducibile agli «altri casi di nullità espressamente previsti per legge», il che esclude l’applicabilità della tutela nei casi in cui il motivo illecito sia determinante. Le ipotesi di nullità contemplate dalla legge sono il licenziamento nullo perché discriminatorio ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell’articolo 35 del codice della pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni, o, ancora, perché riconducibili ad altri casi di nullità previsti dalla legge o in quanto fondati su un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile.
Viene estesa la reintegrazione anche all’ipotesi in cui il giudice accerti il difetto di giustificazione per motivo oggettivo consistente nella disabilità fisica o psichica.
ARTICOLO 3 COMMA 1 LA TUTELA CRESCENTE
Al di fuori di quest’ultima ipotesi, nel caso in cui il giudice accerti il difetto di giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo, è prevista una tutela meramente indennitaria (art. 3).
L’indennità, nella prima stesura era commisurata all’anzianità di servizio maturata, è determinata in misura pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio, con un importo minimo pari a quattro mensilità e un importo massimo pari a ventiquattro mensilità.
Oggi l’indennità non può essere inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità a seguito della modifica intervenuta con d.l. 12 luglio 2018, n. 87 (decreto dignità) a seguito della Sentenza della Corte Cost. 194/2018.
ARTICOLO 3 COMMA 2 TUTELA REALE ATTENUATA
Tuttavia, nel caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
qualora sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento),
il giudice condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Da tale importo (che comunque non può eccedere le dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.) deve poi essere detratto sia l’aliunde perceptum che l’aliunde percipiendum, individuato quest’ultimo in ciò che il lavoratore avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro.
La novità appare rilevante per l’opportuna specificazione circa la necessità che venga provata in giudizio l’insussistenza del «fatto materiale», che risolve i dubbi relativi alla rilevanza o meno dell’elemento soggettivo. Inoltre, la riforma del 2015, non ripropone la formula del quarto comma dell’articolo 18 che prevede la tutela reintegratoria, oltre che per insussistenza del fatto, ogni qualvolta la condotta risulti punibile con sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei CCNL.
Nonostante la stesura della norma che come detto, è evidentemente finalizzata a sottrarre da qualsiasi sindacato del Giudice circa l’accertamento del fatto che deve limitarsi solo e soltanto alla mera constatazione del suo verificarsi, con la Sentenza n.12174 del 2019 la Corte di Cassazione ha condiviso le considerazioni già percorse in merito al significato da attribuire alla frase “insussistenza del fatto contestato” che troviamo nel comma 4 dell’art. 18 nelle formulazione della Legge 92 del 2012 laddove viene prevista la “reintegrazione attenuata”. Le motivazioni della Corte di Cassazione poggiano sulle seguenti ragioni:
La prima per una lettura di natura costituzionale, secondo la quale ogni giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo, non può essere scisso sotto il profilo soggettivo dalla riferibilità del fatto materiale all’agente e, sotto quello oggettivo, la sua riconducibilità “nell’ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità”.
La seconda ragione è che la sentenza fa anche riferimento all’espresso richiamo che l’art. 3 secondo comma del d.lgs. 24 del 2015 fa al fatto “contestato” al lavoratore, così legando la valutazione di questo alla rilevanza dell’aspetto disciplinare che si aggiunge e si lega inscindibilmente all’esistenza del fatto.
La terza ragione è che “la diversa soluzione lessicale adottata dal legislatore del 2015 – che ha implementato la formula che limita i casi di reintegrazione con l’aggiunta dell’aggettivo “materiale” in stretta connessione con l’esplicita estraneità di “ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”- si spiega agevolmente con l’esigenza di dissipare per la nuova disciplina dubbi interpretativi che all’epoca erano ancora ben presenti nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale a proposito del comma 4 dell’art. 18 novellato”.
Dalla tutela reintegratoria resta invece esclusa l’ipotesi del licenziamento intimato in violazione dell’articolo 2110, secondo comma, del Codice civile (licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto prima che tale periodo sia effettivamente scaduto), che rimane priva di disciplina, oggi risolta dalla giurisprudenza nel senso di considerare il licenziamento nullo per la violazione dell’art.2110 c.c. 2 comma che prevede la facoltà in capo al datore di licenziamento solo dopo il superamento del comporto.
In merito segnalo la Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 12568 del 2018, secondo cui è nullo il licenziamento intimato solo per il protrarsi delle assenze dal lavoro, ma prima ancora che il periodo di comporto risulti scaduto. Nella suddetta pronuncia, le Sezioni Unite hanno anche evidenziato il carattere imperativo dell’art. 2110 c.c., comma 2. L’imperatività delle norme va definita in rapporto all’esigenza di tutelare i valori morali o sociali o valori propri d’un dato ordinamento giuridico. La salvaguardia della salute è sicuramente un’esigenza prioritaria all’interno dell’ordinamento, visto che, a norma dell’art. 32 Cost., trattasi di un “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” parimenti a quello del lavoro.
Altri dubbi si registrano in merito alla necessità di una “diretta dimostrazione” di tale insussistenza, che conduce parte della dottrina a ritenere che con tale specificazione vi sia stata un’inversione dell’onere della prova. Una tale soluzione deve essere tuttavia rifiutata: difatti, come sottolinea autorevole dottrina, la prova dell’insussistenza del fatto è necessaria unicamente per ottenere la reintegrazione del posto di lavoro, non per accertare il difetto di giusta causa o di giustificato motivo. Ne consegue che resta del datore di lavoro l’onere di provare in ogni caso la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo del licenziamento; viceversa, il lavoratore, per beneficiare della tutela reintegratoria, dovrà provare l’insussistenza del fatto materiale, potendo, altrimenti, richiedere unicamente la tutela indennitaria.
ART.4 LA TUTELA CRESCENTE ATTENUATA
Infine, nei casi di violazione del requisito di motivazione previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 604/1966, o della procedura disciplinare prevista dall’articolo 7 della legge n. 300/1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna il datore al pagamento di un’indennità (non assoggettata a contribuzione previdenziale) di importo pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. per ogni anno di servizio (art. 4). In ogni caso, l’importo di tale indennità varia tra un minimo di due ed un massimo di dodici mensilità.
Oggi l’indennità va da due a dodici mensilità secondo l’applicazione discrezionale del Giudice.
La disposizione in questione è stata infatti dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Sentenza del 24 giugno 2020, n. 150, della Corte Costituzionale, limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».
Difatti tale criterio, basandosi esclusivamente sul parametro dell’anzianità di servizio, prescinde totalmente dalle peculiarità della fattispecie concreta.
La Corte Costituzionale, in linea con il principio di uguaglianza, che richiede di trattare in modo uguale situazioni analoghe ed in modo differente situazioni diverse, ha chiarito che il giudice «potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell’indennità aderente alle particolarità del caso concreto. Ben potranno venire in rilievo, a tale riguardo, la gravità delle violazioni, enucleata dall’art. 18, sesto comma, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, e anche il numero degli occupati, le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti, richiamati dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966.
A conclusione della Sentenza, la Corte Costituzionale ha invitato il legislatore a «ricomporre secondo linee coerenti, una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell’avvicendarsi di interventi frammentari».
Nell’articolo 4 non trova invece menzione l’ipotesi di violazione del procedimento per il licenziamento disciplinare di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966, che, in base all’ultimo comma dell’articolo 3 del d.lgs. n. 23/2015 (si tratta della particolare procedura prevista dalla Fornero per i licenziamenti per GMO che prevedeva un tentativo obbligatorio di conciliazione da effettuarsi presso la ITL), non trova più applicazione al licenziamento dei lavoratori assunti dal 7 marzo in poi.
ARTICOLO 9 DATORI DI LAVORO SENZA REQUISITO DIMENSIONALE
L’articolo 9 detta invece una specifica disciplina per i datori di lavoro di dimensioni ridotte, verso cui, al di fuori dell’ipotesi del licenziamento nullo o orale, non troverà mai applicazione l’istituto della reintegrazione. Inoltre l’ammontare delle indennità previste dall’articolo 3, comma 1, (ove non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo) e dall’articolo 4, comma 1 (vizi formali e procedurali) è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
Cosa ha prodotto la contemporanea vigenza di due leggi così diverse nella sanzione dei licenziamenti illegittimi?
La disciplina introdotta nel 2015 è dunque destinata a divenire quella generale, man mano che i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 siano condotti alle porte del mondo del lavoro, venendo interamente sostituiti con i nuovi lavoratori assunti dal 7 marzo in poi.
La finalità della riforma, come emerge dalla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, è quella di «rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro» (art. 7), nella convinzione che, una disciplina meno rigida del licenziamento consenta l’abbandono della concezione del posto di lavoro come proprietà individuale e di aderire ad una idea “flessibile” del rapporto di lavoro. Difatti, da un lato, la riduzione delle tutele contro il licenziamento illegittimo sembrerebbe incentivare le assunzioni da parte dei datori di lavoro, dall’altro, l’introduzione di specifiche indennità in cifra fissa consentono al datore di lavoro di preventivare il costo di un licenziamento, eventualmente ingiustificato.
Come si è visto peraltro questo intento è stato disatteso perché il sistema delle tutele crescenti che era stato previsto negli articoli 3 e 4 è stato demolito dalla Corte Costituzionale.
Oggi per l’imprenditore che possiede il requisito dimensionale è davvero difficile poter stabilire a priori il costo della pronuncia di illegittimità del licenziamento che è lasciato alla discrezionalità del Giudice.
Si è discusso molto sulle ragioni che hanno spinto il legislatore a differenziare il trattamento sanzionatorio del licenziamento illegittimo in funzione della data di entrata in vigore della riforma. L’effetto è l’introduzione di una nuova forma di “dualismo” delle regole, questa volta determinato dal semplice momento di stipulazione del contratto a tempo indeterminato. Corollario di tale effetto è che il nuovo regime di tutela si applica – almeno in prevalenza – ai giovani che si affacciano al mercato del lavoro. Ciò potrebbe essere letto come un atteggiamento di favore verso i lavoratori più anziani, ai quali sono stati conservati i privilegi della tutela reintegratoria.
Tuttavia, questa lettura, non tiene conto del mutamento di paradigma del concetto stesso di tutela del lavoro associato alla riforma. Che la reintegrazione rappresenti una forte protezione della stabilità del vincolo è fuori di dubbio. Ciò che, però, va considerato è che tale protezione ha, nei fatti, allontanato la platea dei giovani dal contratto a tempo indeterminato. Il dualismo del mercato del lavoro italiano tra lavoratori anziani protetti dalla tutela reintegratoria e giovani destinati ad accedere al lavoro mediante contratti ad orizzonte temporale preventivamente chiuso e, spesso, sforniti dell’intera protezione normativa e previdenziale tipica del lavoro subordinato, è stata una piaga che ha afflitto le nuove generazioni almeno negli ultimi due decenni. La precarietà dell’occupazione “ai margini”, cui è intrinsecamente connessa l’impossibilità di pianificare il futuro e, quindi, di accedere alle opportunità – anche del credito – destinate ai lavoratori muniti di contratto a tempo indeterminato, ha provocato una drammatica involuzione nel processo di crescita ed emancipazione sociale delle generazioni più giovani. Si tratta di un fenomeno testimoniato non solo dalle statistiche ufficiali, ma anche dalle esperienze personali di gran parte delle famiglie italiane.
Ebbene, la scelta di scambiare la tutela reale del singolo contratto di lavoro con una maggiore opportunità di accedere al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è esattamente il portato del cambio di paradigma del concetto stesso di tutela del lavoro alla base dell’ultimo intervento riformatore.
Lo sforzo finanziario senza precedenti consistente nell’azzeramento – per un periodo di tre anni dei costi previdenziali per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato si combina esattamente con la chiara determinazione di provocare una inversione di tendenza delle imprese con riguardo al modo di determinare le regole di ingaggio con i giovani. Si è trattato, in altri termini, di una operazione di incentivazione delle imprese a riscoprire, non per costrizione ma per convenienza, lo strumento contrattuale fisiologico per l’instaurazione di un rapporto di collaborazione duratura e inserita nella organizzazione produttiva: il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per contro questa scelta ha determinato l’ampliarsi delle differenziazioni irrazionali: in particolare quella tra contratti stipulati prima e dopo il 7 marzo 2015. Né può sostenersi che qui soccorre quella giurisprudenza che ritiene legittime differenziazioni di regime giuridico di prestazioni ad esempio previdenzialiratione temporis. Qui si tratta infatti di situazioni coeve, che coesistono in un medesimo tempo storico, di frequente capita che due lavoratori che fanno le medesime cose presso uno stesso datore di lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato ma sono tutelati in modo difforme quanto al medesimo interesse alla conservazione del posto/contratto di lavoro solo perché uno assunto prima e l’altro dopo il 7 marzo 2015.
La tutela reintegratoria oggi ha ancora un significato?
Sono giunto alla conclusione che la reintegrazione oggi non abbia più un significato pratico. Sono giunto a questa conclusione sulla base di un dato empirico. In tutti i casi di reintegrazione che ho avuto in studio il lavoratore ha sempre optato per l’esercizio del diritto di opzione. La ragione è semplice: venutosi a deteriorare il rapporto con il datore di lavoro, il lavoratore non ha più interesse a ritornare a lavorare in un ambiente ostile. Questo è ancora più vero se pensiamo al fatto che oggi la reintegrazione è perlopiù connessa a licenziamenti discriminatori. Nessun lavoratore di norma accetta di tornare a lavorare per un datore di lavoro che ha posto in essere nei suoi confronti una simile condotta. A me sembra che oggi la reintegrazione abbia al più un efficacia dissuasiva nei riguardi del datore di lavoro. Abbiamo anche visto che, di fatto, non è stata raggiunta la finalità di consentire al datore di lavoro di poter preventivare i costi di una pronuncia di illegittimità del licenziamento. La necessità di ancorare l’entità del risarcimento al caso concreto non pare superabile perché contraria al dettato costituzionale. E’ quindi sempre necessario legare la graduazione del risarcimento al caso concreto, alla gravità della condotta posta in essere dal datore di lavoro, della sua capacità economica e delle condizioni soggettive del lavoratore. Si tratta di una valutazione che deve essere fatta dal Giudice come peraltro oggi già accade. Nel senso di unificare la tutela del licenziamento al fine di ottenere una disciplina omogenea, senza necessariamente passare per la distinzione tra piccola e grande azienda, ricompresa nella valutazione delle possibilità economica del datore di lavoro, sarebbe forse opportuno puntare su una tutela risarcitoria che sanzioni l’abuso del diritto di recesso in generale, assumendo un parametro che possa valere per un’ampia gamma di tipologie contrattuali.
L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .
Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.